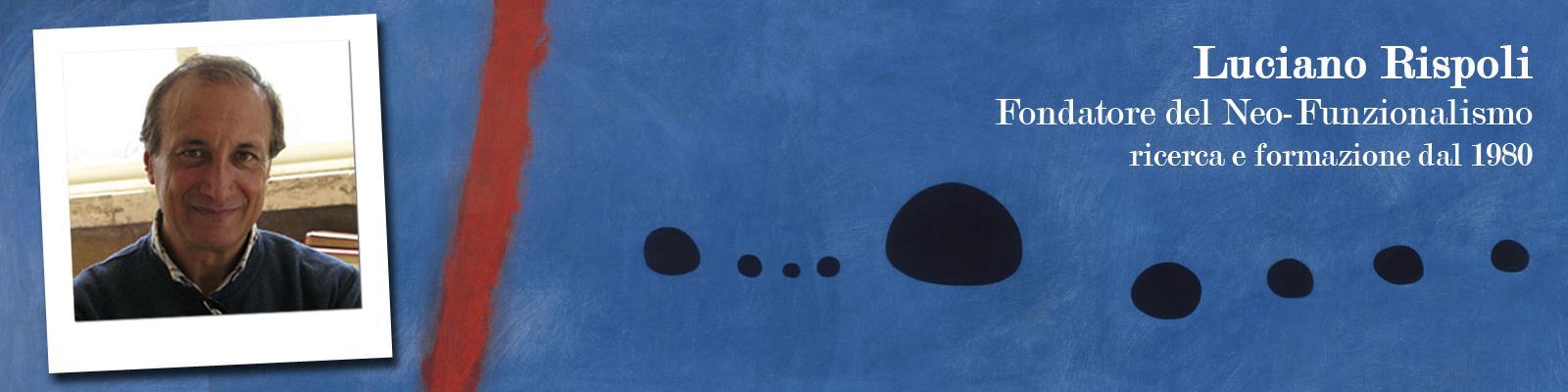in “Quaderni della Scuola Europea di Formazione in Vegetoterapia Carattero-Analitica”, Napoli, 1983.
Quali aspirazioni di obiettivismo e di realismo hanno animato le relazioni degli psicodiagnosti al Convegno SIRP di Napoli? Mi pongo e pongo questa domanda nell’intento di offrire degli spunti di riflessione per la piena comprensione dei parametri entro ed attraverso i quali si vuoi definire un intervento cui sembra si voglia dare sempre più autonomia e dignità di scienza a sé stante: la psicodiagnostica.
Ciò che mi è sembrato cogliere dai Convegno è il tentativo, attraverso affinamenti tecnici, metodologici e teorici, di estendere la portata della diagnosi psicologica il più possibile, sino alla parità con quella di una diagnosi medica. Si insiste sulla correttezza della diagnosi psichiatrica, dell’ interpretazione dei test, dell’individuazione di segni che possano afferire ad un quadro patologico con caratteristiche ben delimitate. Più sono affinati i metodi di indagine, sembrano essere gli assunti di base di una tale impostazione, più ha probabilità la diagnosi di essere esatta. Si chiama in causa una crescente specializzazione delle capacità interpretative dei vari tests, sino a prefigurare per certi aspetti la formazione di esperti in una o nell’altra singola tecnica diagnostica. A questo punto, premessi questi elementi, che per forza di cose non possono rispecchiare la ricchezza degli interventi al Convegno SIRP, ma che rappresentano per certi aspetti alcuni dei punti focali e più interessanti del tema in discussione, possiamo cercare di affrontare i nodi problematici che si rivelano ad una prima ricognizione epistemologica e contenutistica al tempo stesso.
Il primo problema in cui ci si imbatte è una certa difficoltà a conciliare due aspirazioni contraddittorie: una obiettività che si pretende “scientifica” e la valorizzazione della soggettività del diagnosta. Da una parte viene ribadita la necessità di una giusta differenziazione fra diagnosi psichiatrica e neurologica. La diagnosi neurologica, dice giustamente Ancona, può essere solo una parte della diagnosi del comportamento, e nemmeno la più importante. Mentre in medicina e neurologia dal quadro che il paziente offre vengono colti solo indici e icone, elementi collegati al significato tramite contiguità o somiglianza, nella diagnosi psichiatrica sono i segni—simboli ad essere di gran lunga i più importanti, poichè sono altrettante trascrizioni collegate alle profonde radici della personalità, tramite relazioni inconsce e processi associativi i quali in ultima analisi sono in se stessi manifestazioni significative del disturbo psichico. E naturalmente in questo processo comunicativo con il paziente assume importanza non secondaria il mondo simbolico del lo psichiatra stesso, e quindi la capacità di analizzare il proprio vissuto emotivo e le reazioni controtrasferali. E’ ne — cessano che si instauri un profondo rapporto tra decodificante (diagnosta) e chi emette il codice (paziente). Questa circolarità tra i due e il flusso di comunicazioni interdipendenti divengono uno degli strumenti più creativi e nello stesso tempo più potenzialmente adatti a scandagliare ciò che è alla base del comportamento, il livello dei “piani”, direbbero Gallanter, Miller e Pribram, in altri termini la rappresentazione che il paziente ha di sé, del mondo e delle reciproche relazioni. Ma allora che senso acquista un tentativo di ritrovare proprio nella medicina un modello diagnostico al quale riferirsi, al quale avvicinarsi sempre di più, per dare “obiettività” e sapore di “scientificità” alla psicologia e alla psicodinamica?
Perché ritenere che “scientifico” equivalga ad “obbietti vo svalutando così inevitabilmente l’attendibilità di quello strumento costituito dal mondo psichico del diagnosta stesso e dalla sua relazione col paziente? E invece ciò che emerge tra l’altro dal Convegno della SIRP è questa aspirazione alla scientificità intesa come reificazione, che si traduce in una possibile funzione di “smistamento” da assegnare alla psicodiagnostica: inviare dopo la diagnosi il paziente dallo specialista più indicato. Questa funzione è appunto basata sui due seguenti assunti:
1) E’ possibile attraverso diagnosi il più possibile esatte avvicinarsi ad un quadro che ha un riscontro reale ed obbiettivo nel mondo psichico del paziente.
2) E’ possibile prescrivere la terapia più adatta per ciascun paziente. Differenti disturbi, cioè, hanno necessità di terapeuti ed indirizzi terapeutici differenti.
Qui ci imbattiamo in un secondo problema che una simile impostazione mette in evidenza. In psicoanalisi é ormai abbandonata l’idea che la terapia debba consistere in un processo di ricostruzione fedele della vita infantile del paziente. Già Freud sosteneva piuttosto l’ipotesi di una costruzione analitica, in cui ciò che acquista importanza sono gli elementi della relazione che si sviluppa nel corso della terapia e non tanto il riscontro obiettivo nella realtà della vita infantile del soggetto. E quale realtà poi? Una serie di eventi, di movimenti, di scambi la cui sequenzialità esatta si perdeva nello stesso tempo in cui avveniva non piuttosto le tracce nmestiche, le fantasie, le associazioni che il soggetto in terapia realmente ed attualmente produce? La questione in termini generali si presenta sotto il seguente profilo. Il processo psicoterapeutico è una tecnica di intervento su una situazione reale, cioè il malessere di una persona, le sue paure, i suoi sintomi, i suoi comportamenti non accettati (dagli altri o da sé), le sue risposte inadeguate e incapaci di realizzare risultati prefissati. Ciò che rende “scientifico” questo intervento non è il presupposto che quanto di ‘psicologico’ si ipotizza che venga nel mondo interno di quella persona ha un riscontro puntuale nella realtà effettivamente “avviene” così come lo abbiamo pensato o descritto o ipotizzato. Non possiamo dimenticarci che stiamo adoperando un modello che è solo una ipotesi interpretativa della realtà. La realtà è sempre estremamente più complessa e complicata del modello; e non di poco, ma di parecchi ordini di grandezza. In un certo senso sarebbe come pretendere che un di segno possa riprodurre la realtà di una scena. Al disegno non mancano solo le tre dimensionalità spaziali, manca molto di più: mancano gli odori, i rumori, i colori nelle loro svariate sfumature, il movimento, le sequenze, ecc. E a tutto ciò va aggiunta ancora la selezione percettiva di chi assiste alla scena, l’interpretazione basata sul peso maggiore dato ad alcuni particolari rispetto ad altri, la gestalt complessiva in relazione alla strutturazione psìco-affettiva individuale, O, come più imprecisamente si definisce nel linguaggio comune, la “coloritura motiva”. Ciò che si chiede ad un modello per essere “scientifico” non è dunque tanto una indimostrabile fedeltà alla realtà dei fenomeni a cui si applica, quanto piuttosto la sua congruenza interna. Le ipotesi non devono essere ridondanti, nè contraddittorie. La logica delle proposizioni deve essere coerente. Nessuna delle tesi e delle proposizioni che man mano sono ricavate nelle successive formulazioni deve smentire le tesi precedenti o le ipotesi di base. E infine il modello deve, una volta definito l’ambito di applicabilità, poter essere ripetutamente utilizzato in quell’ambito, nonostante tempi e luoghi possano essere diversi. Poichè anche un metodo diagnostico ha una teoria di riferimento, esso è appunto un modello interpretativo dei fenomeni psichici. Una diagnosi, cioè, non è altro che la osservazione e la registrazione di un insieme complesso di segnali che provengono dall’altro ma sempre attraverso una particolare angolazione: quella del modello che si sta usando.
Ne discendono due corollari:
1°) che non è possibile ritenere valida una diagnosi realizzata in un modello interpretativo se si affida il paziente ad una tecnica terapeutica che utilizza un altro mo — dello interpretativo;
2°) che non è possibile perciò smistare una persona al tipo di terapia che gli è più adatta, a meno che non ci si mantenga entro lo stesso modello di riferimento.
Non è pensabile, ad esempio, che uno psicoanalista possa utilizzare nel proprio schema diagnostico una registrazione di sequenze di comportamento al pari di un behaviorista; oppure decidere,i utilizzando i propri strumenti diagnostici appartenenti alla sfera psicoanalitica, che su quel paziente darebbe migliori risultati una terapia comportamentista con tecnica “flooding” o una con tecnica “modelling”. Alla stessa stregua sembra molto improbabile che un gestaltista, per fare un altro esempio, possa utilizzare diagnosticamente l’osservazione di ciò che accade nel corpo del paziente e nel proprio corpo al pari di un vegetoterapeuta reichiano, il cui schema di riferimento teorico comprende appunto l’identità funzionale psiche-soma e l’esistenza della corazzatura difensiva caratteriale e muscolare. Anche un freudiano, seppur entro certi limiti, osserva il corpo del paziente e deduce da esso una serie di indicazioni; ma probabilmente coglierà in massima parte solo ciò che rientra in un linguaggio congruente con la sua impostazione tecnico-teorica: quello simbolico, quei lo che utilizza metafore e metonimie. Per contro l’interpretazione delle simbolizzazioni, sia quelle del paziente che le proprie, non è esclusa dal quadro tecnico—teorico di un reichiano, se visto nella luce di un proseguimento delle elaborazioni 1iane. Ciò fa comprendere come in realtà non si possa parlare di schemi di riferimento completamente chiusi e separati gli uni dagli altri. Esistono tra di essi numerose posizioni comuni, ipotesi di base coincidenti, intersecazioni e punti di contatto significativi. Tuttavia non è possibile confondere una matrice teorica “organicistica” con una “funzionalistica”, un “innatismo” esasperato con un “ambientalismo”. Il modello comportamentale tipico dei behavioristi, quello stimolo-risposta,(S-R), ha implicazioni sia diagnostiche che terapeutiche molto differenti da uno schema che preveda l’intervento e la rielaborazione dell’organismo come mediatore con l’ambiente, cioè di uno schema S-Q-R. Così, continuando il discorso sulle teorie di riferimento, e sull’esempio specifico delle tecniche corporee, difficilmente un terapeuta che non sia un vegetoterapeuta reichiano coglierà i segni di un’eventuale aggressività censurata in una contrattura mescolare della mascella, oppure un 1i livello di angoscia particolarmehte profondo in una respirazione superficiale e in un blocco diaframmatio molto spinto. Ma anche se riuscisse a cogliere alcuni di questi segni non saprebbe come intervenire adeguatamente, così come il neonato che riceve sì informazioni visive, ma per lui complesse e in— comprensibili poichè non le ha ancdra organizzate e inserite in un sistema esperenziale di riferimento. Tutto ciò richiama un ulteriore problema di ordine generale : quanto cioè possa essere realmente separata la diagnosi dalla terapia per quanto attiene al settore della psiche umana. A tal proposito è necessario respingere le facili suggestioni meccanicistiche tipiche di una certa medicina occidentale. Non è detto cioè che in psichiatria la diagnosi sia univocamente determinabile, nè soprattutto staticamente immutabile. Penso piuttosto ad una diagnosi dinamica, cioè ad una situazione che si evolve mutando quadro con le condizioni emotive, ambientali e psicodinamiche che attraversa il soggetto. Possono nascere sintomi nuovi, afferenti ad un quadro clinico del tutto differente; possono insorgere, o meglio riattivarsi, meccanismi di difesa inconsueti; è possibile che si evidenzino tratti caratteriali e comportamentali differenti da quelli presenti al momento della diagnosi preliminare. Insomma, senza voler per questo negare del tutto la possibilità di fornirsi di un quadro clinico iniziale, quello che poi risulta di gran lunga più importante è il continuo intrecciarsi e sostenersi reciproco di diagnosi e terapia durante lo svolgimento della terapia stessa.
Se è vero che uno degli strumenti più ricchi, più complessi ma anche più determinanti in una psicoterapia è proprio il terapeuta, la sua sensibilità creativa, il suo rapporto con il paziente (sia nella terapia che nella diagnosi), allora bisogna riconoscere che la cosiddetta “obbiettività” scientifica (tra l’altro a volte epistemologicamente fraintesa) non solo non convalida, ma anzi restringe l’efficacia dello strumento “uomo”. Cercare delle “prove” obbiettive non è in psicodiagnosi poi così utile per suffragare un’ipotesi interpretativa, la quale comunque si basa per la maggior parte sulla soggettività del terapeuta. Al contrario, costringere entro i limiti del “riscontrabile” la semeiotica psicodinamica può limitare le incredibili potenzialità del mondo emotivo ed inconscio sia del terapeuta che del paziente. Nel chiudere queste note, che vogliono solo essere uno dei possibili spunti di riflessione e di discussione su problemi che si pongono con urgenza significativa alla nostra attenzione, vorrei soffermarmi su un’ultima considerazione. Non è con un’impostazione di tipo “eclettico” che ci si può avvicinare alla soluzione di questi problemi. Per quanto ci sia oggi un flusso molto intenso di scambio di conoscenze, di metodologie e di tecniche, le basi teoriche di un indirizzo terapeutico, di un certo “modello” interpretativo, danno comunque un’impostazione inconfondibile a tutto il rapporto terapeutico: dal ruolo che il terapeuta ricopre, alla stessa concezione di malattia e di salute. L’eclettismo, equilibrismo impossibile tra teorie spesso opposte, non può che sapere di imparaticcio e superficiale. Ci appare più che altro un modo per nascondere la mancanza di una scelta precisa, di una presa di posizione; e quindi come mancanza di una reale identità. Il rovescio della medaglia rivela dunque che ogni modello si differenzia dall’altro per una diversa impostazione teorica di base e per una serie di scelte le cui conseguenze non sono restringibili al solo piano metodologico, né al solo settore scientifico. Ed infatti ogni teoria e ogni modello interpretativo sono profondamente influenzati dalle condizioni storico—sociali in cui nascono e si sviluppano, e nello stesso tempo le influenzano a livelli decisamente significativi in un processo di feedback circolare. La scelta di un modello ha dunque connotazioni e implicazioni politiche non indifferenti, dal momento che da essa dipendono l’individuazione dei probabili fattori eziologici del disturbo, sia sul piano individuale che collettivo, e il tipo di intervento che viene programmato ed attuato sul piano sociale: per la diagnosi, per la cura, per la prevenzione secondaria e soprattutto per quella primaria. Le implicazioni socio-politiche della scelta di una o di un’altra metodologia di intervento sono dunque aspetti non secondari del problema della salute e dell’assistenza socio— sanitaria. Varrebbe pertanto la pena che si facesse il pii possibile uno sforzo per esplicitare queste implicazioni, per capire la logica sottesa all’una o all’altra proposte che vengono presentate in contrapposizione, che si facesse uno sforzo per rendere chiaramente visibile la linea di tendenza di un modello rispetto ;a quella di un altro. Solo in questo assenso si potrà cominciare a parlare realmente di partecipazione alla gestione dei problemi della salute, nel senso di aver compiuto un passo importante nel cammino verso una “società trasparente”.