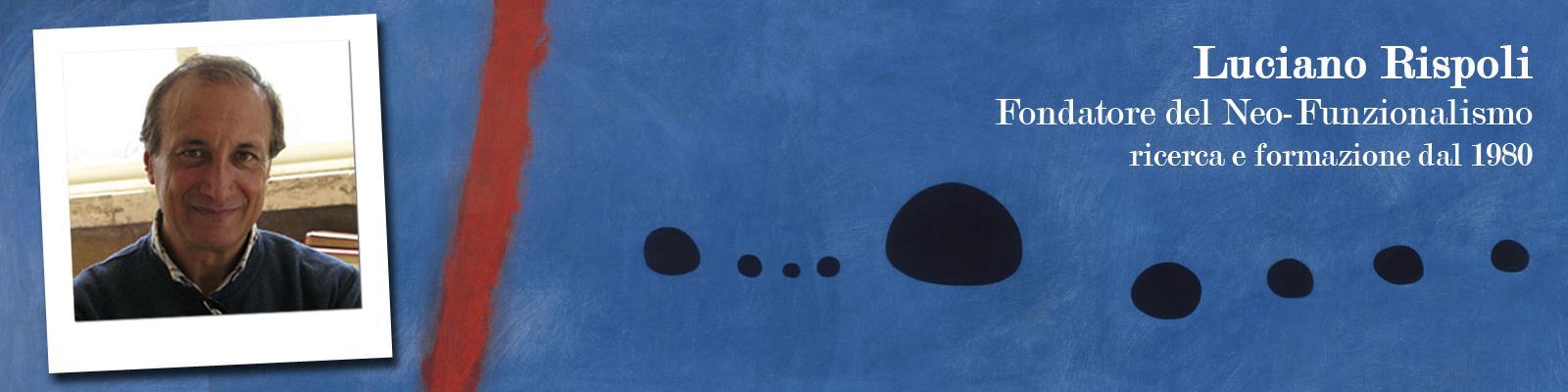Luciano Rispoli, 1990.
Nel seguente articolo, Luciano Rispoli, psicologo e psicoterapeuta, affronta il tema dell’errore in psicoterapia, come possibilità per revisionare e modificare la stessa terapia, ma anche il sistema teorico e tecnico di riferimento.
Anche in Psicoterapia l’errore può essere considerato come scostamento, distanza, allontanamento da una metodologia, da un percorso, da un setting, da una struttura relazionale prefigurata. Bisogna però subito precisare che nella teoria della complessità (a cui sono giunte epistemologicamente le scienze moderne e in particolare le scienze umane e sociali) si è abbandonata la vecchia Formulazione del principio causale (causa-effetto) visto in modo determinato e lineare. Dunque oggi parliamo di causalità circolare, di effetti che ridivengono cause, e in questa concezione va visto l’errore in psicoterapia. Non si può allora sostenere che un singolo errore generi linearmente l’insuccesso della terapia o l’allontanamento del paziente (senza che si sia arrivati al risultato desiderato). E’ comunque fondamentale partire dagli esiti negativi di alcuni trattamenti per poi risalire agli errori (intesi nel senso “complesso” di cui dicevamo prima), e da questi procedere a revisioni e modificazioni del sistema teorico e tecnico di riferimento. Troppo spesso si trascurano i fallimenti, ma il loro studio fornisce un materiale ricchissimo di riflessione e di comprensione dei processi che intervengono nella relazione terapeutica. Lo studio degli errori ci è di grande aiuto anche per comprendere meglio situazioni terapeutiche di impasse, in cui ci si può essere arrestati, o per guardare, alla luce di considerazioni teoriche più generali, in modo più puntuale di quanto in genere si faccia, al collegamento estremamente importante e delicato tra teoria e tecnica. In campo psicocorporeo, in particolare nel nostro indirizzo di Psicoterapia funzionale, risultano ancora più evidenti le possibilità di cogliere segnali anche oggettivamente rilevabili, che ci permettano di confermare o meno le ipotesi che il terapeuta continuamente si pone sullo status quo della relazione.
Ad esempio, l’ipotesi di una fase di transfert negativo nel paziente può essere suffragata non solo da una serie di associazioni mentali o di simboli interpretati, ma anche da tutta una costellazione di gesti, di movimenti di rifiuto e di oppositività, di sguardi del paziente; o addirittura (se la persona è molto abile nel controllare esasperatamente mimica e postura) anche dall’espressione diretta del fisiologico (mani sudate, respiro fermo e vigile, mancanza di allentamento del tono muscolare al tocco del terapeuta, temperatura di alcune parti del corpo, ecc.). Tutto questo ci introduce all’errore visto rispetto alla diagnosi, rispetto alla lettura sia di segnali che provengono dal paziente sia da segnali che sorgono all’interno del terapeuta. Ad esempio può accadere che il terapeuta non si accorga di una condizione di “transfert negativo” del paziente; se ciò accade (in una causalità circolare) sempre meno il paziente riuscirà ad esplicitare il suo vissuto negativo (che confermerà le esperienze ripetitive e frustranti del suo passato) e quasi sempre l’esito sarà un allontanamento del terapeuta, un’interruzione della terapia. Vi è poi un errore rispetto alla metodologia e alla tecnica. Ad esempio una interpretazione sbagliata o data al momento non giusto, un’emozione che il terapeuta non avrebbe dovuto esplicitare, una preoccupazione che venga ributtata sulle spalle del paziente, un intervento su di un piano del Sé non utile per arrivare nel profondo. Quando in una terapia si adoperano più piani della relazione e non solo quelli verbali, come in terapia funzionale, è un errore sollecitare quelle parti del paziente che sono più scisse dai nuclei profondi del Sé, più irrigidite e sclerotizzate. Non serve far muovere sul lettino un paziente che costruisce i suoi gesti in modo controllato e teatrale, far parlare chi è totalmente razionalizzante e già nella vita “falso” (in senso winnicottiano) nella sua verbosità, e così via. Anche questo tipo di errore (come in parte il precedente) ha senso solo nell’ambito della teoria di riferimento. Qui possiamo parlare anche di trasgressioni all’ortodossia. E le trasgressioni hanno avuto spesso il merito di condurre sulle frontiere la ricerca, di trovare nuove vie, di fare delle scoperte, di approdare ad altri sistemi teorici e ad altri modelli (che arricchiscono il panorama clinico poiché illuminano altre zone della struttura del Sé e altri aspetti e fenomeni che intervengono nella relazione). Ci sono poi gli errori rispetto alla costanza o purezza del setting, gli errori nella capacità di contatto o empatia, gli errori relativi alla fase terapeutica in atto (ad esempio non accorgersi di essere arenati nelle fasi iniziali della terapia, non favorire il passaggio a fasi successive, usare tecniche non adatte alla fase che si sta attraversando).
Il caso di Anna.
E’ una terapia portata a termine nell’arco di 98 sedute con una giovane donna che accusava gravissimi sintomi fobico-ossessivi scoppiati “all’improvviso”, che insieme ad attacchi di angoscia e depressione l’avevano completamente paralizzata. La fobia era diventata, alla fine, il pensiero stesso, il solo di fissarsi . Quando terminò il trattamento stava bene. Poi, una serie di eventi fortemente traumatici e davvero incredibili le riscatenarono i sintomi, ancora più angosciosi di prima”. Nonostante fossero evidenti delle cause occasionali esterne, non si poteva trascurare l’esistenza di un “errore” nella prima par te della terapia; altrimenti non si sarebbe dovuta avere una ricaduta. Lo scoprii nella seconda tranche di terapia (felicemente conclusasi). Il livello delle emozioni incapsulate non era stato del tutto aperto. Arcaiche emozioni di paura e di smarrimento, un infantile “gettarsi a terra” (metaforicamente) e disperarsi perché nessuno la veniva a raccogliere, erano rimaste in parte congelate in Anna. Il contatto affettivo si era nuovamente chiuso perché, ancora una volta, davanti a sforzi troppo cerebrali e di volontà (per fronteggiare gli eventi stressanti) il razionale era crollato. Anna ripeteva quel suo “gettarsi a terra”, senza più sentire niente e nessuno: così pensieri fobici e angosce ritrovavano spazio, anche perché le percezioni sensoriali bloccate permettevano una crescita dell’attenzione tutta sui pensieri. Quello che avevo trascurato era che anche in terapia Anna “si gettava a terra” in una disperata perdita di contatto con il terapeuta-padre (la figura della madre era stata accuratamente recuperata). In entrambe le tranches di terapia Anna ebbe 2 momenti cruciali di ricordi e di forte emozione per il padre perso da bambina. La figura paterna che io rappresentavo non aveva (nella prima parte di terapia) sufficientemente aperto l’angoscia abbandonica di quei momenti. Il pianto, i ricordi, le descrizioni non erano stati, come io credevo, sufficienti. E dunque non era stata sufficiente la possibilità di sperimentare strade diverse da allora, di proseguire la relazione col padre attraverso di me, modificarla e portarla a uno sciogliersi sereno. Anche nel nostro campo, dove si lavora normalmente con il contatto corporeo, il problema di una relazione tra terapeuta e paziente si pone molto relativamente se l’intervento è impostato correttamente. Il segreto è di giungere subito a condizioni di regressione molto profonda, attraverso modalità molto precise di intervento sul corporeo (insieme ad un intervento su altri pianti). Ciò evoca intensissimi sensazioni, vissuti corporei, memorie arcaiche, che saltano a piè pari l’innamoramento adulto: la maggior parte della terapia si svolge in pratica sulle stratificazioni del periodo preverbale.
Tutto ciò sarebbe impossibile (e dunque la terapia sarebbe comunque estremamente limitata) se ci fermassimo ad un discorso adulto di relazione amorosa (al di là di ogni considerazione etica).