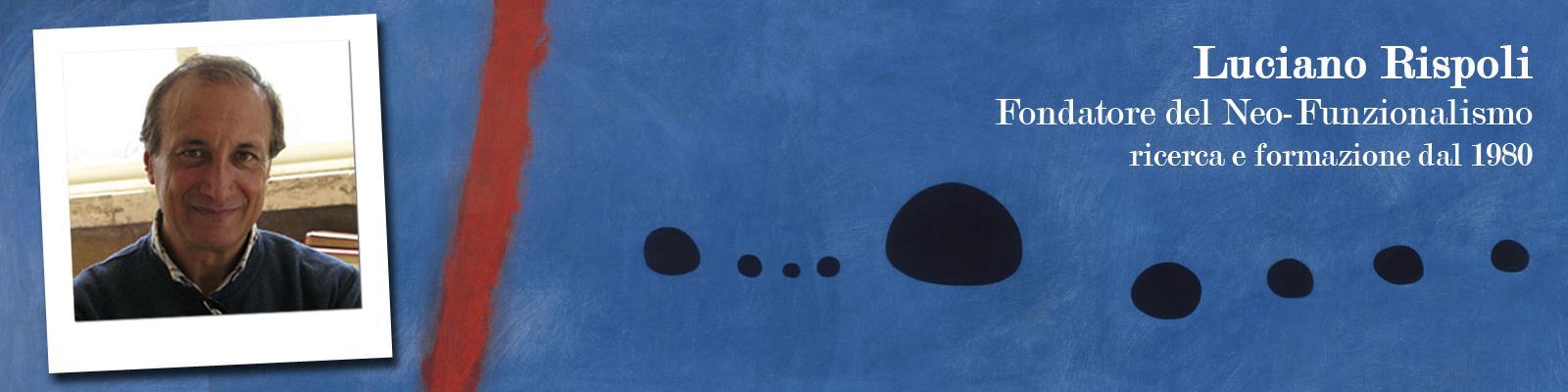Ed. Pagus, Treviso 1993.
Luciano Rispoli, Presidente S.I.F. (Società Italiana Psicoterapia Funzionale corporea), presidente Comitati Scientifici Nazionale e Internazionale per la Psicoterapia Corporea, esecutivo Nazionale Divisione Clinica SIPs, delucida il lettore sulle problematiche connesse alla verifica degli effetti in psicoterapia, data l’attenzione da parte dei ricercatori alla scientificità della terapia psicologica.
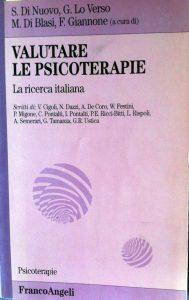
Il problema della verifica degli effetti in psicoterapia (o dei risultati), per quanto complesso, si pone oggi all’attenzione dei ricercatori come un elemento su cui va incentrandosi il dibattito sulla “scientificità” in psicoterapia. È oramai da tempo largamente condiviso il punto di vista che considera la relazione come concetto fondante ed oggetto principale della psicologia clinica. La relazione tra paziente e terapeuta, nell’insieme di elementi passati e presenti che la costituiscono, è infatti al tempo stesso sia il campo di indagine sia lo strumento attraverso cui avviene la conoscenza. Tutto ciò ha comportato notevoli difficoltà, non tanto nel generare ipotesi e teoria (e quindi relative tecniche di intervento), quanto nel momento di costruire uno statuto scientifico generale, e in particolare nella possibilità di validare le teorie valutando gli effetti delle pratiche operative. Su queste difficoltà si sono originati controversi punti di vista e a volte notevoli confusioni, spesso sfociate in sterili contrapposizioni tra soggetivismo e oggettivismo, tra sperimentalisti e sostenitori del metodo clinico descrittivo. Gli sforzi compiuti per chiarire un tema così importante e delicato stanno tuttavia producendo dei risultati nella direzione di un avvicinamento dei due schieramenti. La posizione “ermeneutica”, incentrata sull’analisi del rapporto interprete/testo, mette in evidenza il fatto che ogni vicenda terapeutica è una storia unica ed irripetibile, che però va studiata in rapporto sia alla soggettività del terapeuta sia alla teoria/modello. (Battacchi 1986, Carli 1986, Napolitani 1986). Si moltiplicano le posizioni di chi sostiene come non si possano considerare poi molto lontani i problemi della ricerca sperimentale e di quella clinica. L’epistemologia psicologico-clinica deve poter considerare la compresenza sia di un approccio di tipo “galileiano” (quantità, astrattezza, ripetibilità, ecc.) sia di un approccio “darwiniano” (qualità, contingenza, irripetibilità, ecc.) (Napolitani 1986).
Per studiare un’esperienza dal vivo (aperta ovviamente unica e irripetibile come la relazione terapeutica) non è scontato che si debba usare solo il “metodo storico”, di analisi cioè dell’accaduto tutta all’interno della soggettività del terapeuta. L’oggetto della ricerca, il paziente e la sua relazione con il terapeuta. esistono anche al di fuori della soggettività dei due. Se è vero che i dati di quanto accade in terapia vanno strettamente legati al contesto della relazione (con le sue parti antiche e attuali), se è vero che la loro analisi deve essere condotta rispetto al significato che i dati assumono per terapeuta e paziente, questo non vuoi dire che tale significato non possa essere colto e condiviso anche da un osservatore esterno. Sono note le posizioni di Grünbaum (1984) sulla necessità che anche nelle scienze umane ci si debba basare (non unicamente) su dati rilevabili dall’esterno del fenomeno. Grünbaum raccorcia le distanze tra scienze umane e scienze fisiche, continuando per quella stessa strada che aveva permesso di scoprire come anche in queste ultime non si potesse trascurare l’effetto dell’osservatore sui fenomeni studiati. Preoccuparsi, in psicologia clinica, dei fatto che l’osservatore incida sulla realtà osservata è però fuorviante. L’effetto della presenza dell’osservatore-terapeuta non è infatti un “disturbo”, ma è esattamente quello che ci proponiamo di ottenere. Vogliamo far sì che la presenza e l’azione del terapeuta portino a dei cambiamenti: nella relazione e di conseguenza nella vita del paziente. Il problema allora si sposta nel cercare di capire (e di verificare) in che modo si producano e agiscano questi effetti, e se agiscono nella direzione desiderata. Al di là di certe esasperazioni rivolte alla psicoanalisi, il merito di Grünbaum è quello di aver riproposto la questione fondamentale: se la psicologia clinica possa e voglia essere una scienza oppure no. Noi siamo da tempo tra coloro che ritengono che lo possa e lo debba essere, a patto che si ponga su altre e più rigorose basi il problema della verifica dei risultati. Non si può scegliere la strada dell’isolamento, del rifiuto della scientificità, rifiutando il discorso della verifica, sia all’interno della psicoterapia, sia nel confronto con altre discipline contigue. Non possiamo non rispondere ai dubbi che la terapia funzioni solo in virtù dell’effetto placebo, o grazie al fattore personalità del terapeuta, o addirittura in misura non maggiore alle remissioni spontanee dei sintomi. Lo sviluppo delle conoscenze oggi ci permette di chiarire tali dubbi. I pazienti hanno miglioramenti sostanziali e ben verificabili, e non solo nei primi tempi, sotto l’effetto della speranza e della fiducia, ma anche successivamente se non credono più a quello che fanno, o quando sono sfiduciati oppositivi. Sappiamo che la terapia, quando utilizza molteplici piani del sé, non viene più limitata dal funzionamento del solo piano cognitivo-simbolico, ma agisce su altri livelli, molto al di sotto di effetti placebo e di effetti Rosenthal. Da più parti si insiste sulla necessità di prendere in considerazione il problema della complessità in psicoterapia, e più in generale nelle scienze umane: alla conoscenza risulta indispensabile non solo la descrizione dell’oggetto ma anche la descrizione della descrizione, con una rivalutazione di categorie, come “l’integrazione”, “l’articolazione” alla stessa stregua di altre come “l’opposizione” e ‘la distinzione” (Morin 1983). Il fatto di accettare la teoria della complessità non vuoi dire però rinunciare all’indagine delle variabili in gioco e limitarsi a una visione puramente qualitativa e soggettivistica dei fenomeni. L’utilizzazione di metodologie sperimentali è auspicata da tempo da numerosi autori (Liotti 1986, Sanavio 1986). Ma questo, di contro, non significa voler ricorrere per forza all’esperimento classico da laboratorio, all’isolamento delle variabili; né è necessario far ricorso a metodi statistici di tipo probabilistico (Di Nuovo 1992). E possibile considerare “sperimentali” anche le condizioni in cui si svolgono i trattamenti terapeutici, e valutare la”grandezza dell’effetto” ottenuto, anche attraverso lo studio di pochi casi, se però sono ben definiti gli effetti attesi e l’opzione teorica cui si fa riferimento. Siamo dunque in presenza di una possibilità di ricerca qualitativo-quantitativa, così come siamo in presenza di dati che sono sia soggettivi che oggettivi. Si possono leggere gli accadimenti soggettivi e irripetibili di una relazione terapeutica, il loro svilupparsi e modificarsi, anche attraverso dati oggettivi e condivisibili, non legati al solo mondo interno del terapeuta (o della coppia terapeuta-paziente).
Pensiamo ad esempio alla modificazione del battito cardiaco in relazione ad un cambiamento dello stato di paura o tranquillità del paziente. La persona può ritenere che una certa arcaica paura sia ormai” sciolta”, ma se il battito resta accelerato è un fatto incontestabile che (al di là delle interpretazioni personali e differenti sul perché) in un determinato piano del Sé la paura perduri. Può rimanere soggettiva la risonanza emotiva che la paura del paziente provoca in diversi terapeuti. ma non il fatto che in quella persona ci sia un battito più frequente del normale, uno stato di allarme che continua a persistere e ad incidere anche se inconsapevolmente. Il problema della compresenza di dati soggettivi ed oggettivi si risolve se si fa ricorso a piani di lettura diversi, distinguendo il contenuto (il perché si è cronicizzata in quel paziente la paura e si è scissa dal piano della consapevolezza agendo direttamente sul fisiologico) dallo stato e dalle caratteristiche di queste situazioni, dai meccanismi di base (come si cronicizza la paura, che cosa accade quando si è prodotta una scissione, ecc.). Questione centrale diviene quella di individuare quali elementi, nei processi intersoggettivi, possano essere considerati ripetibili, costanti, comunicabili scientificamente. In ogni processo terapeutico esistono una serie di fenomeni (componenti dell’interazione nella sua globalità) che possono essere rilevati da chiunque sia lì ad osservare, o sia al posto del terapeuta. Un moto di ostilità, anche se inconscia, è per qualche verso visibile, è costituito da un insieme di elementi e di segni concreti (anche se non tutti presenti contemporaneamente) dai quali non si può prescindere. E nessuno può al contrario dire ad un proprio paziente che egli è mosso da ostilità se non c’è almeno uno dei segnali oggettivi di ostilità su un qualsivoglia piano del sé (espressione del viso, tono di voce, fantasie, gesti e movimenti inconsapevoli di attacco, ecc.). Potremmo allora arrivare a dire che l’irripetibile è sicuramente il tessuto di ogni vicenda relazionale, ma che in tutte le vicende esistono e si ritrovano elementi costanti. Questi elementi sono tanto più riconoscibili quanto più si tengono in considerazione i vari “stadi” attraverso cui è scandita ogni vicenda relazionale, e sono tanto più marcati ed evidenti quanto più la psicoterapia procede verso gli obbiettivi e le conclusioni previsti dal modello terapeutico. Sembra dunque possibile individuare due diversi piani. Il piano dell’unicità di ogni storia, di ogni paziente o gruppo, di ogni singola processualità di relazione, è quello nel quale si ritrovano le differenze delle esperienze di vita, così come della formazione individuale di ogni terapeuta, e potrebbe essere definito il piano della narrazione storica. L’altro, nel quale andrebbero posti i criteri di verifica, è il piano della comunicabilità e della ripetibilità: è il piano che potremmo chiamare della narrazione scientifica. Bisogna però precisare che la scientificità in psicoterapia non è da cogliere in rapporti stretti di causa-effetto: non si può collegare interamente l’agire del terapeuta a ciò che accade al paziente. Le leggi che si possono individuare non traducono in equazioni esatte il comportamento di un soggetto in rapporto ai movimenti, frasi, suoni, e gesti dell’altro, i quali nella loro infinita variabilità sono indubbiamente idiosincratici. La costanza è da ricercare piuttosto nelle fasi che scandiscono le vicende terapeutiche, sul piano delle condizioni generali che contraddistinguono e connotano la relazione in ciascun momento. Uno studio sulle regolarità nella relazione clinica scopre momenti differenziati e sequenze di situazioni che si ripetono costantemente in ogni iter terapeutico: un inizio caratterizzato da vissuti molto intensi; un tipico periodo di forte opposizione; una fase di profonda regressione; il ritorno di vecchi sintomi (infantili e adolescenziali); un trasformarsi del modo in cui si percepisce il terapeuta una fase finale che caratterizza la separazione.
Questi momenti, queste “fasi”, hanno necessità di essere sistematizzati in formulazioni di carattere generale, che risultino valide ad una verifica sistematica e continuativa. Occorre allora che siano posti nell’asse teoria-modello (Lo Verso 1989, Pinkus 1978), cioè che siano collocati all’interno di procedure metodologiche e teorie di riferimento chiaramente specificate per ogni singolo approccio. Da queste basi è possibile poi partire per ipotizzare criteri di valutazione e di verifica che si inserivano nel “processo psicoterapeutico” più in generale, andando oltre il singolo particolare modello clinico. Una ipotesi siffatta non può però che rimandare ad una concezione della psicoterapia che possiamo definire “evolutiva”, una concezione, cioè, che ipotizza un procedere per gradi in una certa direzione. Essa definisce cambiamenti e modifiche come moduli di un “continuum” che, proprio perché ricondotto a un adattamento in “evoluzione” può essere in un certo senso misurato e verificato. L’invisibile, l’inconscio, il preconscio, possono essere comunque percepiti tramite segni visibili che li traducono alla nostra capacità di coglierli. Più numerosi sono i piani della comunicazione che vengono presi in considerazione, più numerosi sono i segni che si possono avere a disposizione e maggiori sono le possibilità di cogliere le parti invisibili del mondo del paziente. Il delicato problema del rapporto tra segni e inferenze assume una luce particolare in quegli approcci clinici che investono (per ipotesi di base) un maggior numero di aspetti e funzioni del Sé: movimenti, posture, funzionamento degli apparati fisiologici, schemi cognitivi e comportamentali, ricordi, etc.; come, ad esempio, in un’impostazione funzionale della psicoterapia. Ciò che appare evidente è che le alterazioni del Sé hanno condotto in tutti i casi ad una limitazione della mobilità in senso generale. L’individuo mostra nella relazione col gruppo o con l’altro una prevalenza stereotipata di determinate espressioni fisiche, verbali, emotive e la carenza di altre. Ricercare le carenze di mobilità costituisce una modalità unificata di indagine, che si può articolare in una molteplice varietà di situazioni concrete, in tutti i vari piani del Sé.
Il criterio della “mobilità” potrebbe essere considerato inoltre come una proposta di verifica che superi i confini del singolo modello di terapia. La mobilità, anche se attraverso differenti forme, è un fattore preso in considerazione da tutti gli approcci, un fattore a-specifico rispetto alle differenti teorie che interpretano il funzionamento umano, e specifico invece proprio di quest’ultimo. La mobilità la si può considerare come appartenente alla “vita stessa”.Si può pensare allora di passare ad una fase successiva nella ricerca sulla validità delle psicoterapie, attraverso progetti operativi che in parte siano ancora interni ai vari modelli teorici, ma in parte li coinvolgano contemporaneamente su medesimi obbiettivi, come può essere quello della mobilità. Un progetto del genere potrebbe, ad esempio, essere così articolato nelle sue fasi applicative:
1) Esplicitare in modo chiaro gli obbiettivi significativi che, internamente a ciascun modello, possano essere collegati al criterio della “mobilità”.
2) Analizzare se l’operato del terapeuta ha raggiunto, in un certo numero di casi analizzati, tali obbiettivi.
3) Studiare se i risultati raggiunti da ognuno di questi pazienti sono significativamente riconducibili o meno alle caratteristiche di personalità del proprio terapeuta.
4) Confrontare tra le varie teorie in che termini si sono esplicitati gli obbiettivi legati alla mobilità, e convergere su alcuni condivisibili da tutti.
5) Ciascun modello utilizza poi le proprie tecniche per raggiungere l’obbiettivo-mobilità concordato, ma gli effetti sono valutati con un sistema comune.
6) Collegare, infine, l’obbiettivo-mobilità concordato, inteso come fattore a-specifico rispetto ai vari modelli teorici, con dati misurabili anche a distanza di tempo nei pazienti, e rilevabili anche in coloro che non hanno fatto terapia, su più larga scala, come dato di salute o meglio di “funzionamento” della vita;
E’ a questo punto che gli “effetti” di un intervento terapeutico, ricollegandosi ad un modello più generale di funzionamento, possono assumere l’aspetto di veri e propri “risultati”. Per misurare gli effetti dell’operato del terapeuta è necessaria una griglia di lettura che sia basata in parte su elementi soggettivi (forniti dal paziente e dal suo terapeuta), e in parte su elementi oggettivi, rilevabili cioè da qualunque altro osservatore (che però sia esperto delle tecniche ivi adoperate). Inizialmente si può pensare di formulare una griglia di osservazioni basata sugli elementi portanti di ogni singola teoria. La scheda di valutazione che interverrà nelle fasi successive della ricerca, (quella inter-modelli), dovrà essere invece incentrata sui concetti condivisi della mobilità e delle sue specificazioni insieme concordate. Il problema della “generalizzabilità” dei risultati potrebbe essere affrontato attraverso ricerche inter-modello (come quella che abbiamo proposto), o attraverso l’uso della meta-analisi, confrontando i risultati di diverse ricerche condotte sullo stesso tema. Ma l’efficacia maggiore la si otterrebbe nel confrontare studi appositamente approntati dai vari modelli su obbiettivi comuni e su concezioni condivise (Di Nuovo 1992). L’accordo su obbiettivi di massima potrebbe essere facilitato ricorrendo a criteri empirici, e mettendo in comune le variabili che si sono mostrate più significative e rilevanti.
Oggi forse possiamo già fare qualcosa di più di quello che si può ottenere con una tale logica esplorativa dal momento che da più parti, cominciano ad affacciarsi una serie di ipotesi volte alla costruzione di una teoria generale della psicoterapia (ad es. Basch 1988, Rispoli 1992), la cui importanza, nel poter giungere a obbiettivi e a definizioni operative condivise è certamente evidente di per sé e non ha bisogno di essere ulteriormente sottolineata.